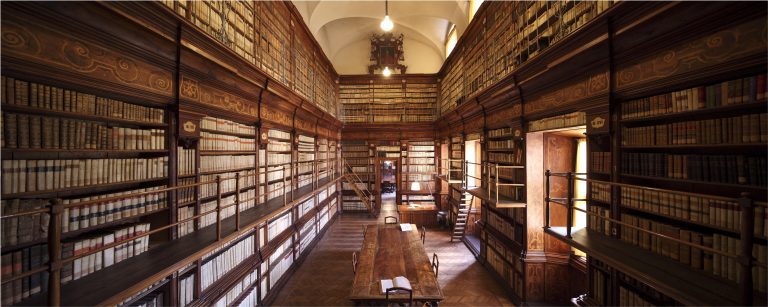Il Collegio Alberoni: profilo storico
Il Collegio Alberoni fu voluto dal cardinale Giulio Alberoni per accogliere i chierici poveri della diocesi di Piacenza.
La formazione alberoniana aveva come obiettivi una «santa educazione» e una «virtuosa direzione», per cui gli alunni dovevano dimostrare docilità, capacità realistica di ricavare il bene da tutto, rispetto per i beni del collegio, distacco dai secolari e capacità di spogliarsi dello spirito del mondo per rivestirsi di quello di Cristo. L’ammissione al Collegio era a concorso. Erano disponibili 54 posti per giovani aspiranti al sacerdozio della diocesi di Piacenza. Il corso di studi era di 9 anni dopo gli studi umanistici, e comprendeva un triennio di filosofia, un triennio di teologia e uno di morale.
Per capire lo stile del progetto educativo alberoniano occorre inquadrarlo nel tempo delle origini. Fu aperto nel 1751. Era un momento di grande apertura. Il fervore illuministico permise di coltivare gli studi di matematica e fisica, di uscire dal chiuso della fisica aristotelica e di aprire ben attrezzati gabinetti scientifici. Nell’Alberoni entrò prestissimo la macchina, cioè il metodo della verifica sperimentale. Se l’apertura al progresso scientifico è una caratteristica saliente dell’insegnamento alberoniano, esso venne non come un dato acquisito, ma come una faticosa conquista. C’era da staccarsi dalla filosofia aristotelica che con molteplici tentacoli imprigionava gli ambienti di studio cattolici in una confusione fra fede e scienza, fra deduzione e induzione, fra metodo sintetico e analitico.
Per questo all’Alberoni si ebbero generazioni di professori molto preparati. Preparazione non vuol dire intransigenza dottrinale. Una caratteristica del metodo alberoniano era appunto la libertà che i maestri lasciavano agli alunni nelle questioni disputate. «Tanto nelle scienze filosofiche come nelle teologiche -scriveva il Bersani, che prima che uno storico era un testimone-…non s’impone nulla, alcun sistema od opinione circa le cose disputabili; ma si lascia a ciascuno piena libertà di tenere quell’opinione che gli sembra più conforme alla ragione e alla fede: … E così accade che gli alunni non riescano tutti coniati colla stessa impronta di un particolare autore o sistema di opinioni, filosofiche o teologiche; ma serbata l’unità della scienza e della dottrina nelle cose necessarie, e il rispetto delle altrui opinioni, ciascuno si forma il suo modo di pensare, e lo conserva finché crede di poterlo sostenere con buone ragioni e lo riforma quando qualche nuova luce venga ad illuminarlo».
In un periodo di astiose contrapposizioni, di furibonde polemiche, furono evitati i pronunciamenti perentori, le difese d’ufficio. In campo dogmatico e morale ci si limitò a partire da ciò che era definito, senza eccedere ad imporre prospettive di scuola.
Per favorire l’approfondimento e l’assimilazione, le materie di scuola erano poche e molto unite fra loro. L’insegnante era chiamato «lettore» ed era affiancato da un «ripetitore».
Dal punto di vista del progetto spirituale non dobbiamo dimenticare che il collegio doveva formare non dei ricercatori, ma dei pastori. Il tipo di prete che emerge dalle Regole degli Alunni del Collegio Alberoni è un uomo «distaccato»: dai parenti, dalle dissipazioni e dagli svaghi inutili, dal mondo. Gli alunni indossavano una veste apposita che segnava l’appartenenza e accentuava il distacco dalla mentalità secolaresca: comprendeva una talare nera, con asole e bottoni rossi, come rossa era la fascia; sul petto dalla parte sinistra vi era lo stemma del cardinale e dalle spalle pendevano le due «redini dell’obbedienza». Il capo era coperto da una berretta di lana di color nero.
Il distacco non può essere quello monastico del “contemptus mundi”, ma quello di un uomo in missione fra gli uomini. Per questo si prevedeva un intenso programma spirituale che non aveva nulla di straordinario o ricercato. Il fondatore della comunità chiamata a dirigere il collegio sapeva che per andare a Dio bastavano i mezzi ordinari, il patrimonio comune della Chiesa.
Il collegio era costruito con fasciame robusto che permise all’istituto di attraversare venti e tempeste. La prima fu a fine settecento, quando i missionari furono accusati di giansenismo. La seconda ebbe luogo nel periodo napoleonico. I Preti della Missione furono allontanati per quattro anni (1810-1814). Nel 1850 i padri dell’Alberoni furono accusati di essere filoliberali e filorisorgimentali. In compenso l’opera educativa del collegio rimase nel tempo e, grazie alla continuità di direzione, è arrivata fino ai giorni nostri.